
Solo da un grande rimorso poteva nascere un così grande atto d’amore.
Dublino celebra oggi il centenario del Bloomsday, cioè dell’Ulisse del “suo” James Joyce, con una serie ammirevole di iniziative che dureranno cinque mesi e che avrebbero perfino del commovente se non ci fossero le ombre pesantissime di un passato neanche tanto lontano a disturbare in sottofondo il clima di festa e di orgoglio cittadino di questo anniversario così singolare.
Singolare davvero, perché il 16 giugno del 1904 non accadde nulla di speciale. Il ventiduenne squattrinato James Joyce, da due anni brillantemente laureatosi in lingue moderne all’University College di Dublino, l’università cattolica, aspirante scrittore che cominciava a guadagnare qualche soldo con le prime recensioni, quel giorno fece delle dichiarazioni impegnative alla sua ragazza, Nora Barnacle, che aveva conosciuto sei giorni prima e che sarà la donna di tutta la sua vita. Niente di straordinario, un fatto abbastanza normale.
Ma quando dieci anni dopo iniziò la scrittura dell’Ulisse, Joyce scelse proprio quel lontano e, soltanto per lui e Nora, fatidico 16 giugno per ambientarvi l’intera vicenda del libro, uno dei capolavori della letteratura del ventesimo secolo. E anche uno dei libri più innovativi, provocatori, censurati, decisivi, difficili, alla fine meno letti della letteratura contemporanea.
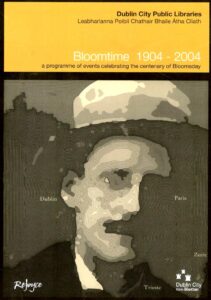
Il giorno più lungo
L’odissea del protagonista Leopold Bloom e del suo compagno di viaggio Stephen Dedalus, l’autore stesso, non dura dieci anni come quella dell’eroe omerico ma, appunto, un giorno solo. Un giorno lungo più di settecento pagine nell’edizione italiana. Un giorno in giro per Dublino, incontrando persone di ogni tipo, nei luoghi più disparati.
Diciotto episodi, altrettanti paralleli con l’Odissea di Omero, tecniche narrative e stili che cambiano continuamente e che stravolgono l’impianto tradizionale del romanzo.
Famoso il monologo interiore o flusso di coscienza. “In Ulisse – dice Joyce – ho registrato simultaneamente quello che un uomo dice, vede, pensa, e ciò che produce questo vedere, pensare, dire…”.
È quel “simultaneamente” il fatto rivoluzionario, perché questo registrare, “documentare”, il flusso apparentemente caotico e sconclusionato (ognuno lo può confermare per propria esperienza) di pensieri di una persona che cammina per la città, incontra altre persone, reagisce a una molteplicità di immagini e situazioni, e fare tutto questo con assoluta sincerità, significa entrare con una sonda implacabile e sensibilissima nelle profondità dell’essere, anche nel sottosuolo dell’anima (parola sempre cara a Joyce, che peraltro ha sempre diffidato della psicanalisi), e tirare fuori l’indicibile, l’impensabile, anche lo sconveniente. Ed esporlo senza addomesticarlo, ricomporlo, ammorbidirlo, e senza rimanerne travolti è un’operazione altrettanto ardua perché significa inventare e controllare un linguaggio adeguato, che non può più essere quello classico, tradizionale, dove tutte le cose sono a posto come in una stanza pulita e in ordine, ma all’apparente caos interiore deve corrispondere un apparente caos del linguaggio che lo descrive.
“Apparente”, perché poi questo caos ha un senso, è il senso di ciascuno e della storia. Non a caso il libro si conclude con un inno alla vita da parte di Molly, la terza protagonista del romanzo, non con lo smarrimento o l’autodistruzione. Dopotutto Joyce aveva pur sempre in Tommaso d’Aquino un costante riferimento.
Ma questo senso per emergere deve farsi largo nell’intrico complicatissimo di ogni esistenza, e di ogni parola e frase (in un’operazione che ha del virtuosistico, Joyce attraversa, per superarli, tutti gli stili che hanno fatto la storia della lingua inglese).
Per questo T.S. Eliot dirà che Joyce aveva “ucciso” il diciannovesimo secolo perché aveva fatto fare alla letteratura – l’arte più adeguata a comprendere l’uomo e la storia – un passo in avanti tale che non sarebbe stato più possibile rimanere ancorati alla pur grandissima tradizione dell’Ottocento. L’ Ulisse segna, dunque, uno spartiacque nella storia della letteratura contemporanea.

Bloomsday 2004: davanti al James Joyce Center in North Great George’s Street. (foto V. Passerini)
Bloom l’antieroe
Il nuovo eroe, Leopold Bloom, è in realtà un antieroe, un uomo normalissimo, sostanzialmente mediocre, pieno di progetti falliti, e per di più ebreo. Il massimo della provocazione per un’epoca segnata dall’antisemitismo diffuso e dal culto dell’eroismo, due malattie che stavano diventando mortali per l’Europa.
Una città, Dublino, che diventa il mondo stesso, anzi l’universo. Perché in questo rivoluzionario romanzo entrano anche la filosofia, la teologia, la letteratura, la musica, la scienza, la politica trattate con passaggi fulminanti, imprevedibili, da togliere il fiato. Dallo sbeffeggio alla solennità.
Il lettore si imbatte in una ricchezza inesauribile di simboli e in una folla sterminata di personaggi del passato e del presente (passato e presente convivono, come i vivi e i morti): cantanti e filosofi, ecclesiastici e poeti, signore e cameriere, nobili, borghesi, giornalisti, bevitori, suonatori, politici, commercianti, professori… Vi entra mezza Dublino dell’epoca, con le sue mediocrità palesi e nascoste, le sue arroganze e ipocrisie, l’atmosfera opprimente che vi si respirava, le arguzie irriverenti e triviali della strada, la sua umanissima quotidianità spogliata dei suoi paramenti e perciò amata da Joyce.
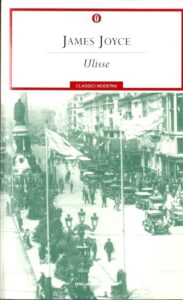
L'”Ulisse” nella classica traduzione di Giulio De Angelis pubblicata da Mondadori.
“Adoro Dante quasi quanto la Bibbia”
E come Dante, Joyce si diverte, con inesauribile ironia e feroce humour, a mettere ciascuno nell’appropriato inferno, purgatorio, paradiso.
Con l’ “Odissea”, è proprio la Divina Commedia l’altro punto di riferimento di Joyce, che amava Dante (“Adoro Dante quasi quanto la Bibbia. Egli è il mio nutrimento spirituale”) e la lingua italiana da lui perfettamente parlata fin da giovane e che coltivava assiduamente andando a caccia di buoni libri italiani non solo in biblioteca, ma anche nelle bancarelle dublinesi (impresa meno difficile di oggi).
Ma l’ Ulisse è anche un libro, come ha scritto Richard Ellmann che di Joyce è stato il massimo biografo, dominato dalla presenza dell’amore, “l’amaro mistero dell’amore”, nelle sue varie forme: sessuale, paterno, materno, filiale, fraterno e, per estensione, sociale.
L’irlandese, anche lui “nel mezzo del cammin” della sua vita, mirò in alto, molto in alto, con una presunzione e una spregiudicatezza che lo avevano già reso a tanti insopportabile, ma con un talento pari alla sfida. E con totale libertà di parola e di pensiero verso la chiesa, che aveva lasciato e che ora intendeva combattere, la patria e la morale dominante. Una libertà che lo aveva spinto, proprio da quel fatidico anno 1904, a lasciare anche il suo Paese e ad andarsene a vivere in Italia.
Peregrinerà per tutta la vita, vivendo quasi sempre in grande povertà, tra Trieste, Zurigo, Parigi e, infine, ancora Zurigo con Nora e i due figli, Giorgio e Lucia, nati a Trieste, ai quali il padre volle dare un nome italiano e con i quali continuò a parlare in italiano per tutta la vita.
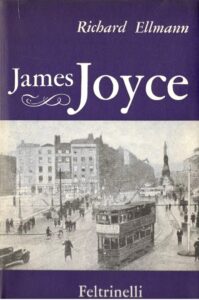
L’imponente (925 pagine) e magnifica biografia di Richard Ellmann dedicata a Joyce (prima edizione italiana Feltrinelli 1964).
L’esilio
Nell’allora importante città portuale asburgica, il cui ambiente cosmopolita e multilingue ebbe un grande influsso su di lui, visse più di dieci anni, fino all’entrata in guerra dell’Italia, e per alcuni mesi anche dopo la guerra, campando di lezioni di inglese alla Berlitz School, o private, di qualche conferenza e articolo di giornale e soprattutto dell’aiuto incessante del fratello Stanislaus che lo aveva raggiunto.
Lo aiutarono anche nuovi amici, tra i quali lo scrittore Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, che da lui prendeva lezioni di inglese e che lo introdusse nella colta cerchia della borghesia ebraica della città. A questa apparteneva anche un’altra allieva di Joyce, la giovane Alice Weiss, che sarebbe diventata la madre di don Lorenzo Milani.
Anni dopo, Joyce aiuterà enormemente Svevo da Parigi facendo conoscere al mondo i suoi romanzi, fino a quel momento snobbati dalla cultura italiana.
A Trieste scrisse le sue prime opere, Gente di Dublino e Ritratto dell’artista da giovane, che per molti anni decine di editori irlandesi e inglesi si rifiuteranno di pubblicare a causa dei loro contenuti anticonformistici e spregiudicati. Rifiuti che accentueranno la sua ostilità verso la madrepatria e rafforzeranno la visione di se stesso come di un perseguitato, se non di un martire, costretto ad andarsene per potersi esprimere pienamente.
A Trieste iniziò anche l’Ulisse, trovando ispirazione e utilissime informazioni nell’ambiente intellettuale ebraico che frequentava.
Il più sontuoso monumento
Eternamente bisognoso di soldi, tentò anche un paio di sorprendenti e improbabili iniziative imprenditoriali, per le quali tornò tre volte, brevemente, in Irlanda.
Insieme ad alcuni industriali triestini tentò di aprire a Dublino nientemeno che il primo cinematografo, novità di cui aveva scoperto le meraviglie. Cercò anche di avviare l’attività di primo importatore di tweed irlandese a Trieste. La vetrina di un negozio di abbigliamento all’altezza del Millenium Bridge sulla riva sinistra del Liffey, il fiume che attraversa Dublino, ricorda con orgoglio questa singolare iniziativa. Ambedue le imprese durarono pochissimo.
Dopo il 1912 non mise più piede in patria, volutamente, anche se Dublino e l’Irlanda furono le amate e odiate protagoniste di tutti i suoi scritti. Come lo stesso Joyce disse al giovane scrittore irlandese Arthur Power che era andato a trovarlo a Parigi e che ostentava il proprio cosmopolitismo: “Lei deve scrivere restando nell’ambito della Sua tradizione … Lei deve scrivere quello che ha nel sangue e non nel cervello. Prima di essere internazionali gli scrittori sono nazionali … Io ho sempre scritto di Dublino perché se riesco a penetrare nel cuore di Dublino posso penetrate nel cuore di tutte le città del mondo. Nel particolare è racchiuso l’universale” (cfr. Ellmann, p. 583).
E così alla sua “sporca”, “paralizzata”, “opprimente” Dublino, l’incompreso, il fuggitivo, l’esule, il cosmopolita Joyce finì per dedicare il più sontuoso e indistruttibile monumento che si potesse immaginare. Ennesimo paradosso di una vita all’insegna dei paradossi.
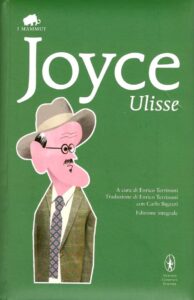
L'”Ulisse” nella recente traduzione di Enrico Terrinoni (Newton Compton Editori, 2012).
Una storica sentenza
L’Ulisse è un libro scritto in volontario esilio da un uomo assolutamente libero e totalmente dedito alla propria vocazione, che non poteva tollerare nessun impedimento, nessuna censura.
Scritto a Zurigo, dove Joyce si era trasferito con la famiglia nel 1915, promettendo “neutralità” alle autorità austriache (suo fratello Stanislaus, irredentista, fu internato a Katzenau per tutto il conflitto), uscì a puntate a partire dal 1918 su una rivista statunitense, “The Little Review”, grazie all’aiuto di Ezra Pound, ma fu bloccato per oscenità da un tribunale di New York nel ’21.
Nel frattempo Joyce si era trasferito con la famiglia a Parigi, incoraggiato da Pound, e nella capitale francese, allora crocevia della cultura mondiale, l’Ulisse uscì in volume nel 1922.
Ai lettori americani sarà però restituito soltanto nel ‘33 con una sentenza della magistratura che fece storia. “L’intenzione e il metodo richiedevano franchezza senza di che si sarebbe caduti nella disonestà” scrisse nella sentenza il giudice John M. Woolsey.
Ma nell’Irlanda clericale e conservatrice, a tratti anche reazionaria, sarà pubblicato soltanto nel 1966, anche se i colti dublinesi avevano già potuto leggerlo nelle edizioni fatte arrivare dall’estero da alcune librerie e dalla Biblioteca nazionale. Quando Joyce morì, ormai famoso, il 13 gennaio del 1941 a 59 anni, a Zurigo, poco dopo aver lasciato Parigi occupata dai nazisti, ci fu perfino un giornale irlandese che liquidò la notizia parlando di “un autore che era nato in Irlanda”. Molti gli erano rimasti ostili.
Ma pochi giorni prima di morire aveva avuto la soddisfazione – ne rimase “incantato”, ricorda Ellman nella sua monumentale biografia – di leggere sull’ “Osservatore Romano”, il quotidiano del Vaticano, una positiva recensione della sua ultima opera, la complicatissima Finnegans Wake, uscita nel maggio del ‘39 e alla quale aveva dedicato tutto se stesso dopo la pubblicazione di Ulisse. I suoi resti riposano ancora nella città svizzera.
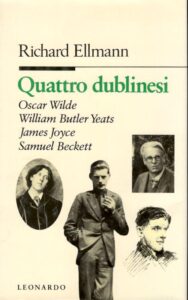
Richard Ellmann in questo libro di 120 pagine (Leonardo, 1989) ci offre un sintetico ritratto di Joyce insieme a quelli di altri tre grandi scrittori dublinesi.
Un happening felliniano
Il piatto del passato pesa, è schiacciato da un macigno. E allora bisogna buttare sull’altro piatto della bilancia tutto quello che si può. Solo un grande rimorso poteva far nascere questo gigantesco centenario.
Ogni anno Dublino festeggia il Bloomsday, ma questa edizione del secolo dà proprio l’impressione del sacrificio espiatorio.
Due anni fa la Biblioteca nazionale d’Irlanda ha acquistato per ben 12,6 milioni di euro un consistente corpus di manoscritti di Joyce dai figli di Paul Léon, che fu il segretario non stipendiato, l’amico e il sostegno dello scrittore negli anni parigini, e che finì inghiottito nell’immensa fiumana dei sei milioni di ebrei sterminati dai nazisti.
Sono questi manoscritti, alcuni dei quali inediti, il cuore della grande mostra “James Joyce e l’Ulisse alla Biblioteca nazionale d’Irlanda” che è stata inaugurata ieri e che anche grazie a nuovi supporti tecnologici intende far conoscere da vicino, come mai prima, il lungo e complesso lavoro che sta alla base dell’opera.
Domenica scorsa, mentre l’Europa votava, c’e stata una colossale colazione per diecimila persone in O’Connell Street, la via centrale di Dublino, dalle nove a mezzogiorno, a base di polpette di interiora di pollo. E spettacoli. Fisarmoniche, violini, cantanti d’opera, eleganze primo Novecento, sosia di Joyce, declamazioni, funamboli, mangiafuoco, maschere. Voglia di festeggiare, ridere, sbeffeggiare.
Un happening felliniano, dove non poteva mancare l’apparizione fugace di una tonaca nera – ossessione onnipresente nella narrativa di Joyce come nel cinema di Fellini – che volteggiava con i trampoli sopra la folla. La maschera ogni tanto planava, si metteva a scherzare con i bambini e poi tornava a sgambettare sopra il tappeto di teste. Lì accanto, dove Earl Street si immette in O’Connell Street, Joyce, fuso nel bronzo da Marjorie Fitzgibbon, osservava con aria imperscrutabile. Colpa della forte miopia e della fortissima presunzione. Dentro, però, il compiacimento doveva essere enorme. L’esule doveva proprio godersi quella rivincita di cui mai aveva dubitato.

Bloomsday, 2004. “Un happening felliniano, dove non poteva mancare l’apparizione fugace di una tonaca nera…che volteggiava con i trampoli sopra la folla… Joyce, fuso nel bronzo da Marjorie Fitzgibbon, osservava con aria imperscrutabile…”. (Foto V. Passerini)
La rivincita dell’esule
Non mancheranno gli inevitabili convegni, le conferenze e le letture pubbliche nelle biblioteche, al James Joyce Centre, all’Università Cattolica. Ma anche nelle birrerie. Mostre di pittura e fotografia un po’ ovunque, escursioni per la città lungo i luoghi dell’Ulisse, rassegne cinematografiche e teatrali, concerti.
Solo Dublino avrebbe potuto festeggiare così il suo Joyce, mescolando sofisticatezze e sagra paesana, acume critico e calore popolare, anima e carne. Che è poi, questa totalità dell’esperienza umana, il dato dominante dell’Ulisse, in ciò dublinese fino all’osso.
Alla Banca d’Irlanda perfino una mostra dei ragazzi delle scuole, “Un Joyce potabile” (dovrebbero dare una medaglia alle eroiche maestre).

Bloomsday 2004, la presidente della Repubblica, Mary McAleese, davanti al James Joyce Center. (Foto V. Passerini)
Spazio speciale per la musica e il canto. Joyce aveva una magnifica voce, come suo padre John, tenore mancato, e da giovane voleva fare il cantante. Amava il teatro d’opera, soprattutto Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni. Passione che non l’abbandonò mai e di cui lasciò vistose impronte anche nel suo capolavoro.

Bloomsday 2004, una gigantesca maschera di Joyce ascolta… Lo scrittore amava molto l’opera italiana.
Coi gesuiti una partita aperta
Tra i tanti concerti in programma, il più interessante, anche per la sede così carica di suggestioni in cui si è svolto, è stato forse “Bloombel”, eseguito più volte nei giorni scorsi nella cappella del Belvedere College, l’istituto dei gesuiti dove Joyce poté frequentare gratuitamente le superiori e dove imparò un metodo per tutta la vita. Dirà un giorno ad August Suter che in quelle aule aveva appreso “a sistemare le cose in maniera da renderle facili a controllarsi e giudicarsi”.
Stimati e confutati, ammirati e dileggiati, i gesuiti furono per lo scrittore maestri e avversari, in una di quelle mastodontiche contraddizioni che solo in Joyce convivevano, soprattutto in campo religioso, e che lo portavano a respingere, anche con durezza, il cristianesimo e la chiesa e nello stesso tempo ad alimentarsi continuamente alle loro fonti e alla loro storia (la figura di Cristo lo affascinò sempre, e così la Bibbia, e così la liturgia cattolica).
“Lei è un mostruoso sistema di contraddizioni” gli dirà, pur ammirandone lo stile, lo scrittore H.G. Wells, riferendosi in particolare alla sua irrisolta commistione di elementi pagani e cattolici, ben sintetizzata d’altronde dal nome di Stephen Dedalus che Joyce aveva dato al secondo protagonista dell’Ulisse, e suo alter ego, e che unisce il primo martire cristiano al primo architetto e scultore della mitologia greca. Joyce ci sguazzava felicemente in quel “mostruoso sistema di contraddizioni”.
La partita tra i gesuiti e Joyce è ancora aperta. Ma ormai lo scrittore non è più per i suoi antichi maestri un rinnegato, una pecora nera di cui non si poteva parlare senza arrossire, ma un figlioccio, per quanto partito per altri lidi, da essi allevato e di cui essere orgogliosi. E da contrapporre anche alla supponenza dell’establishment protestante anglo-irlandese che col predominio politico ha sempre esibito anche quello intellettuale.

Bloomsday 2004: “Bloombel”, concerto eseguito nella cappella del Belvedere College, l’istituto dei gesuiti dove studiò Joyce. (Foto V. Passerini)
“Nessuno come il cardinale Newman”
Allo scrittore i gesuiti hanno dedicato il numero estivo di quest’anno della loro rivista “Studies” (vol. 93, n. 370), con notevoli saggi, tra i quali si distinguono quello di apertura di Peter Costello, uno dei massimi esperti irlandesi di Joyce, e quello di James Pribeck su Joyce lettore e ammiratore del cardinale Newman, grande teologo inglese dalla scrittura superba e fondatore dell’Università Cattolica di Dublino (“Nessuno ha mai scritto una prosa inglese paragonabile a quella di un noioso, pedestre, piccolo parroco anglicano che è poi divenuto un principe dell’unica vera chiesa” scrisse Joyce a Harriet Weaver, sua generosa sostenitrice ed editrice, in una lettera del ’35 (cfr. Ellmann, p. 771; in bibliografia).
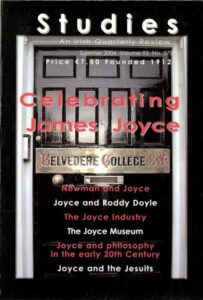
Il numero monografico di “Studies” (estate 2004), la rivista dei gesuiti irlandesi, dedicato a Joyce, il loro più illustre allievo (cfr. Bibliografia).
Il gospel di Gardiner Street
Un secolo non è passato invano, né per i gesuiti né per la chiesa cattolica. Soprattutto per quella d’Irlanda, fino a poco tempo fa rigogliosa e potentissima, e che oggi vive una delle stagioni più drammatiche della sua storia. Irrisioni e umiliazioni hanno preso il posto dei troni e dei trionfi di ieri. La gloriosa Irlanda cattolica sembra non esserci più. La chiesa e i gesuiti sono più deboli, oggi, molto più deboli. Di una umana debolezza così simile a quella di Bloom, perfino fallimentare come quella dell’antieroe di Joyce.
I gesuiti sono pochissimi. Il loro potere forse e zero. Ma essi hanno imparato ad accettare questa debolezza come la forza degli annunciatori del Vangelo.
Se oggi Bloom-Joyce entrasse nella chiesa di San Francesco Saverio in Gardiner Street, la sua vecchia chiesa parrocchiale degli anni del Belvedere College, allora così cupa e minacciosa, retta ancora oggi dai gesuiti, troverebbe un’altra atmosfera. Se vi andasse alla messa della domenica sera, quella dei giovani, troverebbe una chiesa stranamente affollata di questi tempi, un popolo nuovo in festa, un coro di giovani che gioiosamente canta e suona (perfino gli U2), famiglie intere, facce africane e orientali, e un celebrante umanissimo. E allora forse anche a lui verrebbe voglia di unirsi al coro e di battere le mani al ritmo del gospel. E sorriderebbe in cuor suo della comune liberazione.

Bloomsday 2004. Sullo sfondo il Belvedere College.
Bibliografia
Celebrating James Joyce, “Studies. An Irish Quarterly Review”, Summer 2004, vol. 93, n. 370.
R. Ellmann, James Joyce, traduzione italiana di Piero Bernardini, Feltrinelli, Milano 1964.
J. Joyce, Ulisse, traduzione italiana di Giulio De Angelis, prefazione di Richard Ellmann, nota al testo di Hans Walter Gabler, Mondadori, Milano 2003.
J. Joyce, Occasional, Critical and Political Writing, Oxford University Press, Oxford 2000.
J. McCourt, James Joyce. Gli anni di Bloom, traduzione italiana di Valentina Olivastri, Mondadori, Milano 2005.
G. Melchiori e G. De Angelis (a cura di), Ulisse. Guida alla lettura, Mondadori, Milano 2003.
Pubblicato sul quotidiano “l’Adige” il 16 giugno 2004 e, in una seconda stesura, nel libro “Bloomsday” (2011).